Recensione di “Si resti arrinesci”
“Si resti arrinesci. Per fermare l’emigrazione dalla Sicilia”, è il titolo di un libro, pubblicato da “antudo.info”, con Introduzione di Elio Di Piazza. Il volume affronta un tema di grande attualità per l’economia e la società siciliana: l’emigrazione, in particolar modo quella giovanile, con il portato di desertificazione strutturale della Sicilia che questo implica.
“Si resti arrinesci” ha una matrice culturale ben definita e riconoscibile: si inserisce infatti in una critica marxista del capitalismo, considerato alla base delle principali contraddizioni della società contemporanea, tanto a livello globale, quanto a livello locale.
In questa chiave, e con un definitivo superamento di ogni retorica unitaria risorgimentalista, i rapporti economici strutturali tra “Italia” (intendendo come tale quella istituzionale o statale in uno con i territori economicamente egemoni del Centro-Nord) e Sicilia sono letti, secondo la celebre interpretazione di Nicola Zitara, come colonialismo interno.
In questo già Antudo rappresenta, negli ultimi anni, una novità di tutto rilievo nei movimenti popolari, che in passato hanno sì affrontato le questioni operaie, contadine e sociale, ma senza mai mettere in discussione il tabù garibaldino dell’Italia “una” e del “progresso” che tale unità avrebbe rappresentato sempre e comunque per tutti i territori.
La condizione di colonia interna, del resto, è difficilmente oppugnabile, stanti le condizioni di scambio inique tra fattori della produzione a buon mercato da una parte e prodotti finiti ad alto valore aggiunto dall’altro, a voler anche trascurare gli altri aspetti strutturali di subalternità sociale, politica e culturale.
Alla base di un rapporto coloniale c’è sempre uno scambio ineguale, il cui saldo può essere eguagliato solo al prezzo di un continuo depauperamento della ricchezza, anche naturale, del colonizzato a favore del colonizzatore.
Rispetto a questo quadro generale in passato si è forse dato sin troppo peso all’esportazione a buon mercato di beni e servizi del settore primario (le derrate agricole, lo zolfo, la pesca, lo sfruttamento turistico selvaggio), mentre si è trascurato un vero e proprio saccheggio di altro e ben più rilevante fattore della produzione: il lavoro, cioè le risorse umane.
In condizione di naturale surplus demografico – si passi l’analogia – l’emigrazione poteva anche essere vista come parziale appropriazione di plusvalore da parte del colonizzatore, capace di portar via ora risorse non specializzate (quando queste servivano, specie in passato) ora risorse qualificate (come accade da tempi più recenti). Ma oltre una certa soglia lo sfruttamento demografico, sommandosi a politiche deflative e a una spoliazione/annientamento della base produttiva naturale dell’Isola, non raccoglie più solo una parte o la totalità del “frutto”, ma va a intaccare il capitale umano, che così diventa strutturalmente incapace di riprodursi, al contrario depauperandosi.
Come è stato ben detto nel testo, in un contesto di desertificazione, il sempre più preoccupante deficit demografico non è neanche compensato dalla “sostituzione” degli immigrati, da Paesi ancor più poveri e colonizzati. Il testo si limita a rilevare l’impossibilità di questa surroga in termini numerici, giacché la Sicilia non è attrattiva neanche per l’immigrazione, ma molto spesso solo tappa di passaggio, non molto diversamente aggiungeremmo da una Bulgaria o Macedonia qualunque (che pure, non fosse che per la presenza di stato proprio, presentano oggi una condizione molto meno infelice della nostra). Su questo ci permettiamo di notare che, anche ove vi potesse essere una compensazione puramente numerica, il depauperamento delle risorse umane sarebbe comunque grave.
Ovviamente non per vieti pregiudizi etnici, ma perché qualitativamente (a prescindere dal reale grado di formazione nei paesi originari) i “lavori” offerti in entrata sono qualitativamente inferiori, e di molto, alle professionalità in uscita, e questo senza contare che lo stesso dramma che i nostri emigrati provano in termini di sradicamento, incapacità di integrazione e mancanza di definita identità, provano gli stessi immigrati, ciò che peraltro è argomento del tutto marginale riguardo al ben più centrale tema dell’emigrazione di massa.
“Si resti arrinesci” ha – a nostro modesto avviso – una triplice possibile chiave di lettura:
– è un testo storico, alla ricerca delle cause della Questione Siciliana;
– è un testo socio-economico, di interpretazione della realtà in atto, che giustamente trova ben più ampio spazio, anche per mezzo delle testimonianze ivi raccolte, rispetto al retroterra storico di fasi ormai superate dello sfruttamento della Sicilia;
– è infine un testo politico, un guanto di sfida, che pretende di ribaltare le agende politiche dominanti.
Il ribaltamento è infatti già nel titolo, dove il “si nesci” del notissimo proverbio siciliano, si capovolge in “si resti”: una rivoluzione copernicana, che vuole partire proprio dalle scelte di vita che si propongono alle nuove generazioni. La parte più rivoluzionaria del testo è la rinuncia al luogo comune, alla “naturalità” della “valigia”. Già di per sé, al di là delle soluzioni pragmatiche, la presa di coscienza della patologia di questo status, pone una prima condizione per il riscatto.
Nel desiderio di “restare” è infatti soprattutto l’autocoscienza di essere Popolo; Popolo che vuole costruire il proprio futuro nella Terra in cui sono le nostre radici. E oggi, nella dittatura culturale globalista che ci vuole amorfi cosmopoliti, e che ha già buttato come scarpa vecchia l’identità nazionale ottocentesca/novecentesca “italiana”, a ben vedere solo tappa intermedia, dirsi e voler essere Siciliani appare intanto come atto di estremo coraggio.
Altro merito del testo è quello di non diluire la Questione Siciliana nella generica Questione Meridionale, che però è ancora tutta interna al “paradigma nazionale italiano”. Se ne riconosce, giustamente, l’affinità, ma il “Sud” – come già ebbe chiaramente a individuare Gramsci – è un non luogo senza identità, con tutta una gradazione di “semicolonie”, che vanno dai dintorni meridionali della capitale politica d’Italia, alle estreme propaggini della Penisola, abbandonate dallo Stato alle consorterie criminali, molto più che la stessa Sicilia; Sicilia ove non c’è mai stata una “associazione a delinquere” degna di confronto con la ‘Ndrangheta od organizzazioni camorristiche, ma solo un vero e proprio “Dipartimento di Stato coperto”, cioè Cosa Nostra, che ha rappresentato (questa almeno personale interpretazione) lo strumento paramilitare di dominio dell’Italia sulla Sicilia.
Chi separa la natura politica della mafia siciliana dalle sue attività illecite e la assimila ad una qualunque combriccola di delinquenti, o non ha capito nulla o depista. La mafia siciliana, già dai primi esperimenti borbonici preunitari, è SEMPRE stata un’organizzazione politica italiana. Ma anche questa fase appare ormai tramontata, se non per il perenne marchio d’infamia che ci ha lasciato attaccato addosso. Oggi il colonialismo italiano (e sempre più europeo e globale) non ha neanche più bisogno di questi oscuri intermediari locali.
Bene fa il testo, sempre sul piano storico, a riconoscere che a fine Settecento, primi Ottocento, la Sicilia stava sperimentando un processo di evoluzione economica (anche con un capitalismo locale) del tutto analogo a quello di qualunque Paese europeo. Non è ben delineato (ma forse sarebbe stato pretendere troppo, se non altro per ragioni di spazio) la fase di stallo e di stasi nel mezzo secolo scarso delle “Due Sicilie”, dove fatalmente venne a mancare quella protezione statale che altrove sarebbe stata determinante per la Rivoluzione Industriale: il governo borbonico tentò, senza successo, un primo dualismo a nostro sfavore; non vi riuscì; l’economia siciliana arrivò così all’appuntamento unitario con una economia ancora florida, sia pure già drammaticamente priva di infrastrutture. E nondimeno fu una vera anticamera del successivo colonialismo.
La tragedia del 1860, per la Sicilia, è figlia diretta della catastrofe del 1816, dove in un colpo solo – come premio per la vittoria sia pure da comprimari nelle Guerre napoleoniche – perdemmo isole maltesi, Stato, Parlamento, libertà, autonomie civiche, ma soprattutto dignità di Nazione a sé.
Arrivati a Garibaldi senza Stato e identità proprie, siamo stati dissolti in un unico grande “Sud”, anzi come “Sud del Sud”, aggiogati a un carro che non era il nostro. È pur vero che l’emigrazione non venne subito: dovevano passare alcuni decenni perché il depauperamento delle risorse raggiungesse il punto di rottura. Ma la marcia, innescata dal 1816, non poteva che prendere quella direzione.
La Sicilia, stando alle attestazioni storiche, fino al 1700 era stata sempre e solo terra d’immigrazione dal tardo Paleolitico (con le uniche eccezioni “politiche” della fuga in Continente in epoca di invasioni saracene, “controfuga” in Maghreb dopo la conquista normanna, ed espulsione ebraica alla fine del XV secolo; tutte, appunto, eccezioni politiche, non economiche).
Durante le Due Sicilie si ha la stasi totale, con primi segnali di colonizzazione demografica della Tunisia (di cui però il libro non parla) e non pochi esuli politici.
Dopo l’Unità d’Italia, infine, a varie ondate, si diventa terra di emigrazione, con un’accelerazione negli ultimi decenni in cui si perde definitivamente l’equilibrio demografico.
Anche l’epoca fascista forse avrebbe meritato un altro spazio. Fino all’Italia liberale, infatti, il peso politico ed economico della Sicilia nonostante tutto è rispettabile. Ancora una volta è Gramsci a dirci che l’unica industrializzazione, sia pure in tono minore, oltre a quella del Triangolo industriale, sperimentata nell’Italia fin de siècle, è quella siciliana, sia pure osteggiata (ça va sens dire) dal Governo italiano. Il fascismo, con l’autarchia, darà il colpo di grazia a questa industria, e il divario Nord-Sud nel Ventennio, in totale assenza di rappresentanza politica, ancorché clientelare, prenderà letteralmente il volo, per non essere mai più recuperato, nonostante il venticinquennio “felice” post-bellico, che peraltro è l’unico in cui seppure in parte l’esperimento autonomistico sembrava essere preso un po’ sul serio.
Ma questa è davvero storia. E sorvoliamo, solo per motivi di spazio, sulle pur interessanti considerazioni di tipo linguistico e culturale che hanno marcato la progressiva colonizzazione dell’Isola. Le “spartenze” dell’attualità di cui parla il nostro libro hanno ormai una loro spiccata fisionomia, che si lega ad un saccheggio senza precedenti delle risorse siciliane, da quelle finanziarie ancora teoricamente spettanti per Costituzione o per Statuto, a quelle naturali e ambientali. Saccheggio aggravato dall’ormai conclamato dissesto finanziario di uno Stato italiano a sua volta preda della rapacità finanziaria globale, incatenato da un’Unione Europea che di quella finanza è semplicemente il cane da guardia, inibito da una unione monetaria che gli impedisce qualunque politica economica autonoma.
Un’Italia ormai a sua volta deindustrializzata e colonizzata che però mantiene tutto il proprio potere sulle colonie interne, verso le quali mostra un volto sempre più feroce, rivendicando paradossalmente una inesistente “Questione Settentrionale”.
Tutto ciò, non arrestato e portato alle sue estreme conseguenze, minaccia semplicemente di morte la civiltà plurisecolare della Sicilia: e minaccia di vero e proprio genocidio, prima culturale e poi fisico, i Siciliani.
Per questo si saluta come importantissimo il grido di dolore che sale da queste pagine. Si possono condividere o no i punti di vista singolarmente espressi qua e là. Ma il merito di avere sollevato quanto meno il dibattito è indubbio.
Ci permettiamo di fare, sul piano pragmatico, alcune riflessioni che a noi ha suscitato il testo, seppure implicitamente:
1. La resistenza deve essere duplice, su un piano “sindacale” o di sopravvivenza e “politico” di soluzione del problema.
2. Sul primo piano (“sindacale”) si possono e si devono condurre specifiche battaglie a difesa dei territori, ma anche di vera e propria assistenza all’autoimpiego dei giovani pronti a creare il proprio lavoro, una propria famiglia, il proprio futuro, in questa Terra, affinché il titolo del libro non resti una pura speranza, ma sia un’opzione praticabile.
3. Il cuore del problema è però quello politico, e questo a sua volta non ammette soluzioni se non si fa qualche passettino avanti: emancipazione totale dalla rappresentanza politica del sistema italiano – agenda politica che attraverso forme di autogoverno e sostituzione della classe politica coloniale/feudale attuale giunga fino alla vera e propria INDIPENDENZA – rivendicazione, al di là di romanticismi di ogni sorta, della necessità di un vero e proprio STATO DI SICILIA.
Su questo forse ancora non si ha visione nitida. Abituati a vedere lo stato come dominatore, lontano e straniero, ci siamo forse fatti l’illusione che possiamo autogovernarci “solo” con una rete di solidarietà tra piccole comunità locali. Ben vengano. Ma lo Stato ancora serve, eccome. Lo Stato è il braccio armato di una comunità sociale, politica ed economica, e non c’è mai stata emancipazione dalla condizione coloniale se non passando dalla trasformazione dell’amministrazione coloniale in amministrazione statale. Ciò che anche la Sicilia deve fare.
Come Antonio Canepa insegna, si deve passare dalla condizione di Stato Nazione per poi pensare a più ampie forme di emancipazione sociale. Non ci sono scorciatoie. Intanto salutiamo questa presa di coscienza collettiva, che ci auguriamo attraversi i vari segmenti della nostra società, qualunque ne sia l’estrazione o l’orientamento politico e culturale.


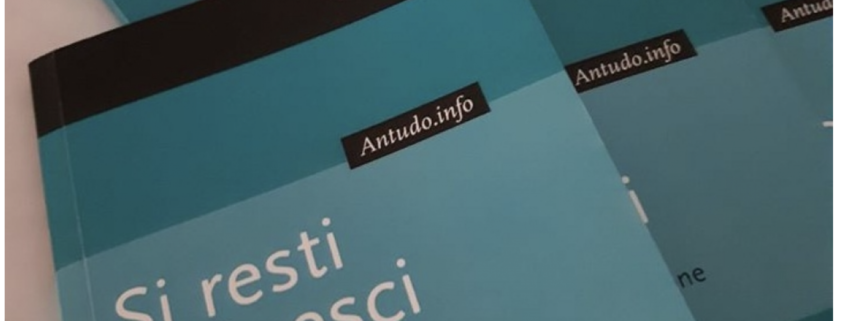
 © Copyright - Massimo Costa
© Copyright - Massimo Costa
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!